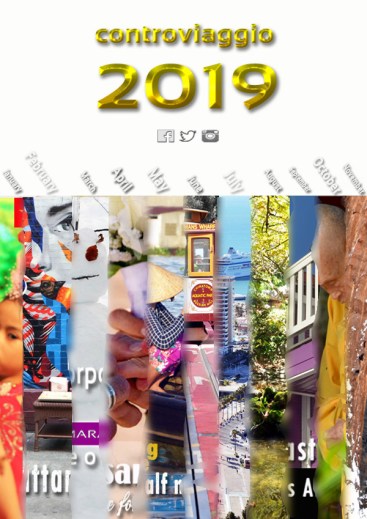Palestine. Through the eyes of a visitor

There are no words to describe the bleak reality of actual humans who are trapped and whose lives are scarred by loss, oppression and uncertainty. And yet, cling to hope against all odds.
I am not writing about the Israeli-Palestinian conflict. If anything, I am acutely aware of my incompetence in this regard. All I seek to do is recount my personal experience against the backdrop of the conflict, and my pain at the treatment of Palestinian civilians by the State of Israel.

On a hot Saturday, as Israel observed the Shabbat, we headed to a Bedouin village in the Negev desert.
What struck us instantly was the hospitality and warmth of the Bedouins. Their homes had been demolished a few days ago, but their spirit was not broken. Under a makeshift arrangement, women chatted and cooked a meal. The children were all smiles as they greeted us and shook our hands eagerly, before darting off to play and find some shade from the scorching sun. We sat under a tree and were served coffee, followed by tea.
The is one of the many “unrecognized” Palestinian villages constantly targeted for demolition. The Israeli authorities claim that the land is state property. The Bedouins have ownership registered under the Ottoman rule and the British Mandate. The State of Israel does not recognize their title deeds.
Over the years, the village of Al-Araqeeb has been subject to frequent demolitions. When we met them, we were informed that over the past 60 days, their houses were broken down 25 times. And in the latest hearing, the Israeli judge openly directed and aided the prosecution when it came to utilizing aspects of the law against the Bedouins.
(For background, read about the Jewish National Fund’s reforestation of the land and the plan to “Judaise” the Negev.)
The leader, Sheikh Sayyah Al-Turi, has been the focal point of the Bedouins’ non-violent struggle against the land-grab. He has been arrested numerous times and has around 50 court cases slapped on him by the State of Israel. The attack on him is systematic and consistent — physically, emotionally, financially.
A polite, but imposing personality, he exuded no hatred. Just the steely determination to keep fighting, however hopelessly, against the might and power of the state.
Someone asked him, “Where do you get your strength from?” He very matter-of-factly responded, “This is my land. This is my home. It protected and fed my ancestors, and my family. I must fight for it.”
As we got up to go, a lady told him, “You shall be in my prayers.” He smiled gratefully and responded, “In your prayers, also remember people all over the world who are suffering injustice, that God will strengthen and comfort them.”
 When we met Mr A, his first words were, “Welcome to the world’s classiest prison.” Though he was jovial guy and sported a big grin, I found it hard to even smile. The Separation Wall and watchtower in Bethlehem loomed menacingly; Banksy graffiti providing little relief.
When we met Mr A, his first words were, “Welcome to the world’s classiest prison.” Though he was jovial guy and sported a big grin, I found it hard to even smile. The Separation Wall and watchtower in Bethlehem loomed menacingly; Banksy graffiti providing little relief.
He told us how once upon a time he and his friends used to hang out at pizza joints and coffee shops and drive around listening to music. But those days are gone. To feel good, some people may buy a car. But others see it as a waste of money because “there is nowhere to go”.
We asked him why he does not venture “out of the prison” more often. “You cannot imagine how it feels to get interrogated like a criminal every single time”, he burst out in frustration. His answer made us realize how insensitive and clueless we were to the everyday experiences of Palestinians.
For Palestinians to enter Israel, they have to pass through checkpoints. Over there, the contents of bags are examined and scanned. They could be asked to remove their belts. Their documents are scrutinized. They have to explain the reason they want to get to the “other side”. There are 42 types of exit permits (eg: college, medical treatment, day-time jobs such as construction work in Israel, pray at a holy site, attend a function or a funeral, visit relatives) for which they have to pay for.
At any given point in time, there could be hundreds or even over a thousand waiting to cross over. Once cleared, they have to wait for organized transportation on the other side. This could take up considerable time, and their eventual passage rests on the discretion of the young military officers manning the checkpoint, laden with combat gear and ammunition.
At times, the checkpoint could shut down and no one is permitted to leave.
It is humiliating and dehumanizing.
During a conversation, he pointed to the rooftops which had water tanks. “For every 250 litres of water an Israeli household gets, the Palestinian equivalent will be around 48 litres.”
“They make it so bad that they hope we will leave. But I have nowhere else to go. This is my home.”
We pass by a group of kids playing. They give us the sweetest smiles and enthusiastically wave hello. We go to click a photograph and a few of them shout with alarm, “No No, don’t take photo”. A lady with us blew them a flying kiss, with pure innocence they grin and return the gesture.

I remember reading that Hebron is like a movie set with no actors. Yet, nothing prepared us for reality.
Abandoned. Eerie. Desolate. Deserted. Run down. A ghost town.
Israel has implemented a strict segregationist policy in Hebron and the Palestinians residing here are extremely marginalised. The settlers deliberately pick fights with them and this gives the police the legitimate right to come knocking on their doors in the night and drag them out.
We met the owner of a shop who told us that his store has been attacked and ransacked on several occasions over the past years, and the wares sometimes destroyed.
Another man showed us the bullet scar on his leg.
We had lunch in Mr M’s house. He lives there with his entire family. He told us that he has been beaten black and blue on numerous occasions by the police.
At one time, an Israeli settler put a gun to his head. When he lodged a complaint with the Israeli police, they asked him for the name of the aggressor. Despite seeing the incident captured on military camera installations, the police registered the case against an “anonymous” attacker since Mr M could not produce the full name. The next day in the street, the settler grinned and made a gesture at him.
Every time there are the sound of bullets, he tells his children that those are wedding celebrations. He instructs them to greet the military and police with a “Shalom”. As long as he can, he wants to protect his children from harsh realities and not instil fear in them.
In the market, there is a small stretch with shops owned and run by Palestinians. Israeli settlers have moved into houses above the bazaar and toss garbage, eggs, dirty water, used diapers, and sometimes pour urine, onto the street below. As a result, the shopkeepers have had to put up sheets of corrugated iron. In no time, the Israeli authorities got them dismantled and prohibited such coverings. Hence, a wire mesh to prevent the “big” trash from falling in front of their shops has to suffice.
The harassment of the Palestinians is done with the sole aim of getting them to flee in frustration and replacing them with more settlers.
It is impossible not to leave Hebron with a heavy heart.

The Palestinians could be Druze, Christians, Muslims or Bedouins. But they are human, like you and me. They are faced with tumultuous circumstances and very real threats that are ugly, stressful and often violent.
Children are not spared either. Bedouin children have been thrashed by settlers on the way to school. Due to international pressure, the military was forced to accompany the children to prevent physical abuse.
Yet, while they bear witness to the loss of life, shelter, protection and possessions — they have not lost hope. They fervently pray and wish for a better tomorrow. If not for themselves, at least for their children.
They never asked us for money.
They never asked us for clothes.
They never asked us for food.
They never asked for charity.
All they asked was that we tell their story.
Hanoi. The guide

Il gruppo di anziani attendeva impaziente di essere imbarcato sul volo che nel giro di qualche ora gli avrebbe trasportati fino l’altra parte del mondo. In Vietnam. Gli acciacchi fisici derivanti dalla terza età non avevano impedito a nessuno di farsi trovare pronto nell’affrontare un viaggio piuttosto impegnativo. In aeroporto ogni partenza era caratterizzata da un brontolio generale riguardante la mancanza di posti a sedere, la scomodità della seduta, i prezzi elevati dei bar ed ovviamente il disordine delle file al momento dell’imbarco. Di inframezzo la lista delle malattie affrontate o da affrontare. Come se lo scambio delle figurine che praticavano da bambini avesse ripreso moda anche nella vecchiaia. Le raffigurazioni dei calciatori erano state però sostituite con quelle delle artrosi, cervicali, diabeti e patologie tiroidali. La capogruppo, un’energica piccoletta un pò più giovane rispetto agli altri, si prodigava nel mantenere il gruppo unito, cercando di assecondare il più possibile ogni loro esigenza. Chi doveva andare urgentemente in bagno, chi voleva acquistare le parole crociate, chi gironzolava a vuoto per sgranchirsi le gambe. Gli uomini si intrattenevano per lo più discutendo di politica spiccia. Le donne intervenivano energicamente quando si trattava di elencare i disservizi presenti nel Belpaese. Dalle affermazioni convinte si evinceva che la causa attuale di tutti i mali, o quasi, erano gli extracomunitari. Gente pericolosa che, quando non dedita alla macchia, rubava posti di lavoro e case agli italiani. Tra loro c’era anche chi sosteneva che questa tesi era una sciocchezza, ma veniva ben presto tacciato da coloriti esempi di furti, rapine, violenze e qualsiasi altra ingiustizia quotidiana commessa dai forestieri. Man mano che l’orario di apertura del gate si avvicinava, la sala si popolava di passeggeri in attesa. L’aumentare del vociare e la presenza sempre più ingombrante delle persone fece distogliere ad un ragazzo lo sguardo dal monitor del portatile che stava maneggiando e che rifletteva il suo viso dai tratti orientali. Smise di armeggiare la tastiera, si levò delle corpose cuffie dalle orecchie e si rivolse ad una signora del gruppo per invitarla a sedere al posto suo. La gentilezza non fu ricompensata. La donna si impossessò del posto senza ringraziare. “Era ora” si limitò a bofonchiare.
In attesa del loro arrivo ad Hanoi la guida vietnamita aveva ingannato il tempo chiacchierando con l’autista del pullman che stava anche sostenendo il cartello con stampato il nome del gruppo. Era una ragazza minuta con poca esperienza alle spalle e fresca di laurea ma ciò nonostante non tradiva alcuna insicurezza. Alle uscite si era creata parecchia confusione vista la presenza di professionisti del settore e parenti o amici in attesa dei loro cari. Questo non aveva impedito alla guida di individuare subito il gruppo. Le voci di varie nazionalità si accavallavano tra loro creando un trambusto infernale. A queste si aggiunse il rumore delle rotelle delle valigie strascinate dai visitatori ed i nomi urlati per non disperdersi. L’umidità completava il disagio. Quasi tutto il gruppo si lamentava delle condizioni poco confortevoli in cui erano costretti a sottostare, mentre la tour leader tardava ad arrivare. Più di qualcuno fece subito notare alla guida vietnamita che in Italia certe cose non sarebbero mai potute accadere. Finalmente arrivati al bus e caricate le valigie a bordo presero posto defaticandosi e rinfrescandosi con l’aria condizionata erogata dalle bocchette.
La guida estrasse quindi il microfono, si accertò che funzionasse, poi con la sua voce delicata e con un accento marcatamente orientale si presentò dando il benvenuto ai nuovi ospiti. Il chiacchiericcio sul fondo riguardante la scomodità dei sedili impedì a più di qualcuno di capire cosa stesse dicendo. Si augurarono che il resto delle spiegazioni fosse più chiaro rispetto a quello trascorso. La capogruppo si preoccupò di chiedere se all’arrivo in hotel fosse stato adibito un buffet dato che erano piuttosto stanchi ed affamati. Ulteriore timore per niente velato fu quello di accertarsi che l’eventuale cibo fosse commestibile. Impensabile per un italiano cibarsi di solo riso, appuntò. La guida dovette necessariamente interrompere le prime spiegazioni quando notò che tutti erano inevitabilmente distratti dal caotico traffico di Hanoi. Non si fecero certo attendere i commenti sull’inadeguatezza di alcuni mezzi circolanti e la promiscuità del codice stradale. Qualcuno volle specificare che in Italia cose così sarebbero impensabili. Anche al sud.
Il tragitto da percorrere per raggiungere l’hotel era particolarmente breve ma la densità del traffico allungava i tempi. La guida ne approfittò per riepilogare il programma che avrebbero affrontato nei tre giorni di presenza ad Hanoi, prima del loro trasferimento all’interno del Paese dove sarebbero stati accolti da un’altra guida. Illustrò quindi la passeggiata serale che avrebbero fatto attorno al West Lake, il lago della leggenda della spada restituita, con la visione illuminata del ponte rosso Hoan Kiem. Struttura che avrebbero attraversato anche il giorno seguente e che li avrebbe portati all’interno del tempio Ngoc Son. Complici la fame, la stanchezza e la pronuncia non proprio perfetta della guida la maggior parte sembrava assopita nei propri pensieri e poco attenta al discorso. Si risvegliarono tutti immediatamente quando qualcuno con voce decisa chiese alla guida se c’era il segnale per il wifi. La spiegazione riguardo questa problematica si svolse durante la sosta ad un semaforo rosso a pochi metri dal Tempio della Letteratura dedicato a Confucio. Intenti a smanettare i propri smartphone come adolescenti all’uscita di scuola, nessuno fece caso ad un gruppo di studenti neo laureati che stava festeggiando la fine dell’attività scolastica sfoggiando sorrisi e gioia per il riconoscimento conseguito.
La guida riprese a fatica, ma sempre con il sorriso sulle labbra, a raccontare dello spettacolo delle marionette che si svolge al Thang Long Water Puppet Theatre. Prima dello spettacolo avrebbe fatto assaggiare loro il famoso caffé all’uovo di Hanoi portandoli tutti in una tipica caffetteria locale. Subito i signori chiesero spiegazioni riguardo questa variazione che andava a sfidare il caffé espresso, orgoglio italiano. Di similitudini, a parte la materia prima, non ce n’erano. Qualcuno si informò se, a parte l’assaggio folcloristico di questo caffé all’uovo, ci fosse la possibilità di bere un buon caffé espresso anche in Vietnam. Altri ci scherzarono sopra, ma non troppo, riguardo la possibilità di correggerlo con la grappa.
Finalmente si cominciò a percepire un pò di buon umore che lasciò spazio alla preoccupazione durante l’attraversamento del quartiere vecchio e le numerose bancarelle ai cigli della strada allestite per l’assaggio di cibo di ogni genere. In questo caso tutti sollevarono perplessità riguardanti le condizioni igieniche vista l’esposizione diretta degli alimenti agli eventi atmosferici e l’inquinamento dei mezzi transitanti a breve distanza. In Italia li avrebbero messi al bando in men che non si dica.
Erano quasi giunti in hotel quando una signora affermò che si aspettava tutt’altro dal Vietnam. In mente aveva sconfinate terrazze di risaie arrampicate su verdi e rigogliose colline. Cose che avrebbero visto a Sapa, qualche giorno dopo.
La guida consapevole della loro stanchezza trovò inefficace continuare a parlare di Hanoi. Rinunciò così a descrivere la fotografia che avrebbe fatto scattare loro a Khâm Thiên, dove il treno passa a pochi centimetri delle case.
Ringraziò il gruppo ricordando che a breve sarebbero giunti a destinazione, quindi ripose il microfono nel suo alloggio e si sedette nel posto a lei riservato. Sospirò e scambiò incomprensibili parole con l’autista che intanto stava attraversando il lungo ponte di Long Bien, orgoglio vietnamita.
Fece qualche minuto di silenzio prima di venir bussata sulla spalla da una passeggera seduta dietro: “Mi scusi se la disturbo” la guida si girò verso di lei sorridente “ma anche qui da voi siete pieni di extracomunitari?”
Berlino. Le parole che non sai

Lo scontro tra i due era stato piuttosto violento e questo causò la separazione.
Era giunto il momento di fare un punto della situazione, di stare da soli e riflettere sugli errori commessi. Di scegliere se puntellare definitivamente un sentimento più che mai traballante o lasciarlo volare via come un inutile palloncino al vento. Dopo anni di parole, gesti e respiri condivisi pareva assurda, ad entrambi, ogni minima rinuncia.
 Il cielo di Berlino quella mattina ben si adattava all’umore di lui che aveva deciso di dedicare del tempo a se stesso in una delle città europee più simboliche dell’epoca attuale. Il viaggio era stato travagliato. Il sedile accanto al suo era rimasto vuoto fino a quando fu occupato da una passeggera probabilmente sua coetanea. Le osservò sbadatamente le mani, notò degli anelli argentati, un piccolo tatuaggio sul polso. Una serie di bracciali forse regali o ricordi di qualche viaggio. Per un attimo la guardò in viso ed incrociò il suo sguardo. Non era la persona che abitualmente viaggiava con lui, pensò. Fece un sorriso di cortesia, ricambiato, poi si incupì nuovamente.
Il cielo di Berlino quella mattina ben si adattava all’umore di lui che aveva deciso di dedicare del tempo a se stesso in una delle città europee più simboliche dell’epoca attuale. Il viaggio era stato travagliato. Il sedile accanto al suo era rimasto vuoto fino a quando fu occupato da una passeggera probabilmente sua coetanea. Le osservò sbadatamente le mani, notò degli anelli argentati, un piccolo tatuaggio sul polso. Una serie di bracciali forse regali o ricordi di qualche viaggio. Per un attimo la guardò in viso ed incrociò il suo sguardo. Non era la persona che abitualmente viaggiava con lui, pensò. Fece un sorriso di cortesia, ricambiato, poi si incupì nuovamente.
 L’albergo in cui avrebbe dormito a Berlino era in una zona centrale ed era stato scelto da lei. La prenotazione era a nome della ragazza ed essere costretto a pronunciarlo al momento della registrazione gli provocò fastidio allo stomaco. Un misto tra rabbia, delusione e sacrilego. La camera dell’albergo era atipica e curata nei minimi particolari. Appoggiò la valigia e la esplorò con una prima occhiata notando un letto dall’aspetto confortevole e dalle dimensioni piuttosto grandi, poi si soffermò su alcuni quadretti e specchi appesi ad una parete. Aprì le porte del bagno e della doccia e, prima di sedere sulla poltrona di velluto, aprì le tende in modo da poter ammirare un murale dipinto su una parete nel cortile. Senza quel tocco artistico sarebbe stato un ostacolo alla vista e nient’altro. Si soffermò a scrutare altri oggetti nella stanza, poi sospirò lasciandosi cadere in un sonno profondo.
L’albergo in cui avrebbe dormito a Berlino era in una zona centrale ed era stato scelto da lei. La prenotazione era a nome della ragazza ed essere costretto a pronunciarlo al momento della registrazione gli provocò fastidio allo stomaco. Un misto tra rabbia, delusione e sacrilego. La camera dell’albergo era atipica e curata nei minimi particolari. Appoggiò la valigia e la esplorò con una prima occhiata notando un letto dall’aspetto confortevole e dalle dimensioni piuttosto grandi, poi si soffermò su alcuni quadretti e specchi appesi ad una parete. Aprì le porte del bagno e della doccia e, prima di sedere sulla poltrona di velluto, aprì le tende in modo da poter ammirare un murale dipinto su una parete nel cortile. Senza quel tocco artistico sarebbe stato un ostacolo alla vista e nient’altro. Si soffermò a scrutare altri oggetti nella stanza, poi sospirò lasciandosi cadere in un sonno profondo.
 Girare una città sconosciuta da solo era una delle cose che riteneva più stressanti in assoluto. Durante il cammino era infastidito nel imbattersi in opere d’arte senza avere la possibilità di poterle condividere. Così come le persone che incrociava non avevano nessun motivo di esistere se non potevano essere commentate, spesso scherzate, nel gioco che erano soliti fare i due ragazzi. Era semplicemente un training di complicità piuttosto che malizia o cattiveria. Spunti per ridere assieme.
Girare una città sconosciuta da solo era una delle cose che riteneva più stressanti in assoluto. Durante il cammino era infastidito nel imbattersi in opere d’arte senza avere la possibilità di poterle condividere. Così come le persone che incrociava non avevano nessun motivo di esistere se non potevano essere commentate, spesso scherzate, nel gioco che erano soliti fare i due ragazzi. Era semplicemente un training di complicità piuttosto che malizia o cattiveria. Spunti per ridere assieme.
Prese la metropolitana per raggiungere Alexander Platz. L’unica cosa che lo distraeva dal suo pensiero fisso erano le decine e decine di murales che lo accompagnavano ovunque. Mentre immagini malinconiche scorrendo velocemente dal finestrino del treno testimoniavano il cambiamento dei tempi, cominciò a pensare che forse tra lui e Berlino qualche similitudine esisteva. Scese ad Alexander Platz.
 Nella piazza, che trovò piuttosto sporca, c’era una manifestazione che denunciava un progetto di riqualifica di un quartiere storico. Contestavano l’F24 Alpha, questo il nome del piano di lavoro, di voler innestare delle case moderne ed accessibili per pochi privilegiati a discapito degli storici residenti attuali. La forma di protesta pacifica era originale se non altro. Persone truccate e vestite da zombie si spostavano sostenendo dei cartelli con scritte in tedesco. Il gruppo di protesta si chiamava Die Verdrängten, quelli repressi tradotto. Era tutto molto curioso ma l’interesse finì al termine della sfilata. Decise di mangiare qualcosa in un locale nei pressi della stazione. La famosa Alexander Platz non l’aveva entusiasmato. C’é da dire che in quelle condizioni psicologiche forse ben poche cose sarebbero riuscite a smuoverlo. Sorseggiò il té cercando di individuare qualche notifica di lei sullo smartphone ma ovviamente il nulla.
Nella piazza, che trovò piuttosto sporca, c’era una manifestazione che denunciava un progetto di riqualifica di un quartiere storico. Contestavano l’F24 Alpha, questo il nome del piano di lavoro, di voler innestare delle case moderne ed accessibili per pochi privilegiati a discapito degli storici residenti attuali. La forma di protesta pacifica era originale se non altro. Persone truccate e vestite da zombie si spostavano sostenendo dei cartelli con scritte in tedesco. Il gruppo di protesta si chiamava Die Verdrängten, quelli repressi tradotto. Era tutto molto curioso ma l’interesse finì al termine della sfilata. Decise di mangiare qualcosa in un locale nei pressi della stazione. La famosa Alexander Platz non l’aveva entusiasmato. C’é da dire che in quelle condizioni psicologiche forse ben poche cose sarebbero riuscite a smuoverlo. Sorseggiò il té cercando di individuare qualche notifica di lei sullo smartphone ma ovviamente il nulla.
 Impostò google map in direzione Checkpoint Charlie e lì si diresse. Una volta raggiunto rimase nuovamente deluso da quello che una volta era stato un’importantissimo e spesso tragico passaggio tra Occidente ed Oriente. Una delle tante assurdità architettate dall’uomo adesso era diventato un teatrino del ridicolo con dei personaggi vestiti da militari americani ma dagli accenti albanesi o rumeni, intenti a farsi fotografare dai turisti che avrebbero conservato fasulle e fittizie immagini del momento.
Impostò google map in direzione Checkpoint Charlie e lì si diresse. Una volta raggiunto rimase nuovamente deluso da quello che una volta era stato un’importantissimo e spesso tragico passaggio tra Occidente ed Oriente. Una delle tante assurdità architettate dall’uomo adesso era diventato un teatrino del ridicolo con dei personaggi vestiti da militari americani ma dagli accenti albanesi o rumeni, intenti a farsi fotografare dai turisti che avrebbero conservato fasulle e fittizie immagini del momento.
 Proseguì il cammino fino ad arrivare al perimetro di ciò che rimane del muro di Berlino. Il simbolo per eccellenza della divisione e massima espressione dell’idiozia umana. Potere, avidità, incomprensione, ottusità. Ogni mattone che è stato posto su quella linea divisoria rappresenta i sentimenti più inumani possibili immaginabili. In molti hanno cercato di scavalcare quel muro, in pochi ce l’hanno fatta. I meno fortunati sono ancora oggi ricordati da foto o nomi che a leggerli ci si vergogna. Ma quanti muri di comodo resistono nell’oblio generale ancora oggi? Pensò il ragazzo mentre fotografava uno dei tanti simboli rimasti in memoria. Poi pezzi di muro che frenano schizzi di vernice in cerca di spazi infiniti da colorare. Che nascondono treni in movimento o persone di passaggio.
Proseguì il cammino fino ad arrivare al perimetro di ciò che rimane del muro di Berlino. Il simbolo per eccellenza della divisione e massima espressione dell’idiozia umana. Potere, avidità, incomprensione, ottusità. Ogni mattone che è stato posto su quella linea divisoria rappresenta i sentimenti più inumani possibili immaginabili. In molti hanno cercato di scavalcare quel muro, in pochi ce l’hanno fatta. I meno fortunati sono ancora oggi ricordati da foto o nomi che a leggerli ci si vergogna. Ma quanti muri di comodo resistono nell’oblio generale ancora oggi? Pensò il ragazzo mentre fotografava uno dei tanti simboli rimasti in memoria. Poi pezzi di muro che frenano schizzi di vernice in cerca di spazi infiniti da colorare. Che nascondono treni in movimento o persone di passaggio.
 Alzò lo sguardo davanti all’imponente porta di Brandeburgo, ennesimo sigillo al potere, alla grandezza. In contrapposizione al monumento ancora proteste e rimostranze contro il sistema. La più curiosa era mossa da un uomo super fisicato che sotto una gigante bandiera tedesca elencava agli innumerevoli passanti motivazioni letteralmente insignificanti. Le foto assumevano contesti goliardici piuttosto che politici e le risatine delle ragazze intente a scattarle ne erano la conferma. Più il ragazzo sfiorava l’ilarità più ne subiva l’effetto contrario. La sua malinconia aumentava di sproposito nel vedere gli altri ridere e divertirsi.
Alzò lo sguardo davanti all’imponente porta di Brandeburgo, ennesimo sigillo al potere, alla grandezza. In contrapposizione al monumento ancora proteste e rimostranze contro il sistema. La più curiosa era mossa da un uomo super fisicato che sotto una gigante bandiera tedesca elencava agli innumerevoli passanti motivazioni letteralmente insignificanti. Le foto assumevano contesti goliardici piuttosto che politici e le risatine delle ragazze intente a scattarle ne erano la conferma. Più il ragazzo sfiorava l’ilarità più ne subiva l’effetto contrario. La sua malinconia aumentava di sproposito nel vedere gli altri ridere e divertirsi.
 Arrivò presto la sera e si ricordò che in tutto quel tempo non si era neanche minimamente interessato di bersi una birra. Non farlo in Germania era impensabile. Si sedette così in un locale storico della metropoli tedesca e sfogliò lentamente il menù. Pensò alla birra che avrebbe gradito la sua compagna e ne ordinò una per sé ed una per lei. Simbolicamente. Come se si fosse assentata un attimo e da lì a poco avesse preso posto accanto a lui. Come è sempre stato d’altronde. La cameriera prese l’ordine, si guardò in giro in cerca della seconda persona che ovviamente non era presente ed essendo tedesca, notò l’anomalia, ma non commentò.
Arrivò presto la sera e si ricordò che in tutto quel tempo non si era neanche minimamente interessato di bersi una birra. Non farlo in Germania era impensabile. Si sedette così in un locale storico della metropoli tedesca e sfogliò lentamente il menù. Pensò alla birra che avrebbe gradito la sua compagna e ne ordinò una per sé ed una per lei. Simbolicamente. Come se si fosse assentata un attimo e da lì a poco avesse preso posto accanto a lui. Come è sempre stato d’altronde. La cameriera prese l’ordine, si guardò in giro in cerca della seconda persona che ovviamente non era presente ed essendo tedesca, notò l’anomalia, ma non commentò.
 Le birre aiutavano a far scivolare i turbamenti e liberare le fantasie. I pensieri si accavallavano nella sua testa in maniera disordinata e copiosa. Le proteste, i murales, i monumenti, i turisti, il muro… Già il muro. Che lui aveva condannato fermamente senza lasciare spiraglio a nessuna giustificazione era lo stesso che aveva innalzato dentro di sé. Un muro che lo divideva dalla persona che più aveva amato ed amava in quel momento. Per orgoglio, per stupidità, forse per qualcuno degli stessi motivi che il muro di Berlino aveva causato così tanto imbarazzo al mondo intero. Loro stavano facendo lo stesso in fondo, avevano cominciato una guerra fredda in cui ogni sentimento buono che cercava di scavalcare il muro veniva soppresso. Lasciato cadere a terra esanime. Quante carezze, quanti baci erano stati ammazzati fino ad ora? Persi per sempre.
Le birre aiutavano a far scivolare i turbamenti e liberare le fantasie. I pensieri si accavallavano nella sua testa in maniera disordinata e copiosa. Le proteste, i murales, i monumenti, i turisti, il muro… Già il muro. Che lui aveva condannato fermamente senza lasciare spiraglio a nessuna giustificazione era lo stesso che aveva innalzato dentro di sé. Un muro che lo divideva dalla persona che più aveva amato ed amava in quel momento. Per orgoglio, per stupidità, forse per qualcuno degli stessi motivi che il muro di Berlino aveva causato così tanto imbarazzo al mondo intero. Loro stavano facendo lo stesso in fondo, avevano cominciato una guerra fredda in cui ogni sentimento buono che cercava di scavalcare il muro veniva soppresso. Lasciato cadere a terra esanime. Quante carezze, quanti baci erano stati ammazzati fino ad ora? Persi per sempre.
Il primo boccale di birra era terminato. Il muro cominciava a vacillare.
 Non ha senso tutto ciò, pensò. Come posso permettermi di giudicare gli altri se sono io il primo ad erigere delle barriere verso le persone a cui tengo di più?
Non ha senso tutto ciò, pensò. Come posso permettermi di giudicare gli altri se sono io il primo ad erigere delle barriere verso le persone a cui tengo di più?
Si fece coraggio. Impugnò il telefono e mandò un messaggio: Quando torno ti dirò un sacco di parole che non sai. Che non ti ho mai detto. Sono uno stupido.
Rimase a fissare lo smartphone per tutta la durata della seconda birra, sorso dopo sorso, in attesa di una risposta che non arrivava.
Rassegnato ed annebbiato da tutta quella quantità di alcool ingerita posò il bicchiere vuoto sul tavolino e mise goffamente una mano in tasca alla ricerca del portafoglio.
Nel mentre ci fu una vibrazione.
Va bene, quando torni ne parliamo, lesse.
Sorrise, ringraziò la cameriera intenta a servire altri tavoli e tornò in albergo.
Amatorialissimi: Intervista a Maurizio De Angelis

“Comincio a pianificare la gara con un vero atleta, Maurizio De Angelis, che mi propone di correre in coppia. Ma lui merita un capitolo a parte” scrivevo nel post precedente a questo.
Ed eccolo qui il capitolo a parte.
Correre in coppia… Stando alle sue aspettative avrei addirittura dovuto sostenerlo psicologicamente nella fase finale della 60ma Maratona di New York. Peccato che pochi secondi dopo il via Maurizio era già scomparso dai radar con un ritmo gara piuttosto spinto per i miei standard. Addìos. Ci siamo rivisti in serata nella hall dell’albergo dove abbiamo fatto una bella chiacchierata.
Di cosa ti occupi?
Sono un impiegato della ditta Cooperlat di Jesi, mi occupo di programmazione della produzione e turnazione dei dipendenti.
Quali sport pratichi?
Atletica, nuoto, ciclismo, triathlon, volley, kyte surf.
Pratichi sport da quando eri bambino? Quando sei passato all’agonistica/prime gare?
Si, sin da bambino pratico sport, a Falconara Marittima negli anni 60-70 la pallavolo dominava su tutti gli sport compreso il calcio. Infatti avevamo la squadra di volley maschile nel campionato di serie A. Ed io giocavo al volley, anche se non ero un gran giocatore, sino ai primi anni 90 con squadre di categorie inferiori.
La scoperta del podismo è stata casuale perché durante una delle tante preparazioni atletiche pre-campionato, correvamo con tutti i componenti della squadra, a loro rimaneva sempre difficile invece per me era di una facilità estrema. Da lì mi sono accorto di questo ed ho continuato a correre in solitaria abbandonando il volley (anche perché iniziavo ad avere una certa età).
La prima gara podistica, una 15K cittadina con un po’ di salita, poi via via tante gare podistiche del circuito marchigiano e della mia prima maratona nel 97′ senza aver mai fatto un lungo più di una 21K. 3 ore e 13 minuti a Roma. Nel 98′ feci il mio personale nella maratona con 2.51’23” a Venezia.
Nel frattempo scoprì anche il nuoto per cercare al fisico di dargli un po’ di respiro e purtroppo mi innamorai anche del nuoto master e iniziai a partecipare a diversi meeting.
Nuotavo ma soprattutto correvo tutti i giorni ormai era diventata la mia prima passione e con un altro mio collega di squadra decidemmo di coronare la corsa iscrivendoci alla Marathon des Sables nel 2004 (corsa sulla distanza di 240K che si svolge interamente nel Sahara marocchino ndr)
Quante ore della settimana dedichi all’allenamento? (bici/corsa/nuoto)
Ora pratico sport tutti i giorni ma vario almeno in una settimana: il lunedì corro e nuoto, martedì bici in estate ed in inverno un’ora di rulli, mercoledì corsa in pista, giovedì corsa e nuoto, venerdì riposo, sabato bici e nuoto, domenica bici o gara di triathlon d’estate
Che sensazione provi ad indossare un pettorale?
Indossare il pettorale è come prendere la scossa di 220 volt…. mi scuote il torpore che qualche volta si posa dentro di me… e scaturisce in adrenalina, ogni volta che partecipo ad una manifestazione mi prometto sempre di rispettare il passo… invece se fisicamente sto bene cerco sempre di sfiorare il massimo. (me ne sono accorto… ndr) Sono consapevole di sbagliare ma è più forte di me.
Sei molto competitivo? Consideri la gara una sfida verso gli altri o verso te stesso?
Si mi sento molto competitivo come avrai capito da quello che ho risposto sopra. È una competizione solo ed esclusivamente contro me stesso. Non mi interessa del tempo degli altri, nella gara sono solo punti di riferimento “in quel frangente” altrimenti con altri atleti c’è sempre uno scambio di info o altre volte ci si aiuta negli allenamenti e addirittura nella gara. Cito un segmento della mia esperienza della Marathon des Sables quando in una tappa io ed il mio compagno di squadra abbiamo aiutato un altro italiano a terminare la tappa senza interessarci alla nostra posizione finale e questo è stato un bellissimo gesto. (non è scontato durante una gara)
C’é una gara alla quale hai partecipato che hai particolarmente a cuore? Aneddoti a riguardo?
La mia prima maratona a Roma nel 1997 , il mio personale a Venezia nel 1998 , Marathon des Sables nel 2004 resterà sempre nel mio cuore perché è stata una gara di endurance e sopravvivenza, aneddoti. Di quella c’è ne sono vari da raccontare, come ho già accennato sopra io con il mio compagno di viaggio abbiamo aiutato un ragazzo di Treviso che era in difficoltà; essendo disidratato non aveva più la forza di continuare una tappa, il mio zaino che pesava 13 kg e quello di Marco Olmo che ne pesava 6 …ed alla fine ho diviso il mio cibo con Marco.
La più faticosa (anche nella preparazione)
La più dura è stata la Maratona di Milano il 9 aprile scorso… dopo 12 anni dall’ultima maratona ho deciso di cimentarmi ancora con la regina dell’atletica, non è tanto la fatica fisica ma la costanza degli allenamenti e la paura di non riuscire ad arrivare con la forma per affrontare un obbiettivo prefissato (a 57 anni non è come a 40 che tutto è scontato) comunque è uno stress psicologico più che fisico.
Solitario o social?
Mi piace condividere sui social i miei obbiettivi, sia dei “Trionfi” che delusioni comunque il raggiungimento di un obbiettivo. Ho un profilo su FB ed Instagram, molti amici sportivi e mi interfaccio con loro.
Il tempo dedicato allo sport ti porta benefici anche nel campo lavorativo o allenarsi frequentemente è un impegno ingombrante?
Gli allenamenti portano benefici in tutti i campi: familiare, lavorativo e sportivo chiaramente; alla sera mi sento equilibrato vedo le cose nella maniera giusta questa è la dimensione dopo un allenamento. Mi alleno dopo le 17.30 quando esco dal lavoro
Progetti futuri?
Mi sono iscritto ad un Ironman completo a Klagenfurt a luglio 2019. Per chi fa triathlon e un sogno terminarlo, dato che 3.600 mt di nuoto, 180K di bici e 42K di corsa alla fine credo che per uno sportivo “normale” siano abbastanza duri. Speriamo bene.
Sogno (o sogni) nel cassetto?
Sogni nel cassetto …si con il mio allenatore di nuoto abbiamo deciso che quando avrò 80 anni e lui 50, mi accompagnerà ai mondiali di nuoto master per fare i 1500mt in vasca lunga. Non è uno scherzo.
Segui una dieta particolare?
No, non seguo nessuna dieta, mangio tradizionale una dieta mediterranea, non mi faccio mancare niente, a 57 anni se sacrifico anche il cibo alla fine lo stress aumenta. Chiaramente non bevo liquori, né vino; bevo birra con un’ottima pizza, un bel dolce a fine pasto, non mi faccio mancare niente sempre nei limiti.
Hai avuto (o hai) un atleta di riferimento?
No non avuto nessun riferimento non ho un idolo
Un suggerimento/incoraggiamento a chi vorrebbe incominciare a praticare uno sport quali nuoto/bici/corsa o tutti e tre assieme
Consigli, suggerimenti ne infondo tanti… a Falconara che è una cittadina di pochi abitanti ci si conosce e i falconaresi mi vedono sempre correre per le strade della cittadina e sono il loro riferimento per la corsa, nuoto e bici.
…ed il kite surf. Ma quella è un’altra storia ancora.
La Maratona di New York (vista da dentro)

Anche la melodia della sveglia pare diversa questa mattina.
Le luci esagerate a Time Square non hanno lasciato spazio al buio della notte così come incessanti suonano tra le mie orecchie le sirene dei mezzi di soccorso che transitano tra le vie di New York.
Sulla sedia della scrivania davanti al mio letto ho disposto tutti gli indumenti che dovrò indossare. Un gesto che non si limita alla praticità; è un rito spirituale che serve a riordinare le idee e che i maratoneti conoscono bene. Sistemare con cura pantaloncini, calze, integratori… Spillare il numero sulla canotta e poi osservarlo pensieroso per qualche minuto.
Mi lavo i denti guardandomi allo specchio e stamattina quel banale gesto assume una forma di solennità.
Finiti i preparativi esco dalla camera dell’albergo.
Già la colazione svela un’infinità di differenze tra coloro che prenderanno il via alla 60ma edizione della New York City Marathon.
Non riesco a fare a meno di sbirciare nei piatti delle persone. Siamo quello che mangiamo, diceva qualcuno; nello specifico penso che mangiamo come corriamo.
Fuori la temperatura è fresca, ma non gelida. Non si intravedono nuvole e si prospetta una bella giornata a differenza dell’anno precedente.
L’organizzazione ha già cominciato a sistemare le transenne sotto gli occhi vigili della polizia. Le sirene delle volanti ruotano ad intermittenza illuminando con fasci luminosi blu la base dei grattacieli. Grossi automezzi azionano ad ogni manovra acuti segnali acustici ritmando il frenetico ed ordinato lavoro dei volontari ed operai dai caschi gialli e giubbini catarifrangenti.
Mi sento un puntino perso nell’Universo nell’assistere a ciò che sta avvenendo. Sembra così fantastico prenderne parte.
I bus giungono al molo e le persone infreddolite attendono di salire sul traghetto.
Manhattan indossa ancora il suo bellissimo abito da sera mentre scorre tra le finestre dell’imbarcazione che ci sta accompagnando alla partenza. Non ho con me nulla per poter immortalare ciò che vedo. In un primo momento ho qualche rammarico, ma prevale l’intimità del momento. Sarà il mio cuore, supportato dalla mia memoria, a ricordare ciò che sto vivendo. Ormai non c’è dubbio che la giornata è una parentesi meteorologicamente perfetta e l’alba che si riflette tra le acque del fiume Hudson, che stiamo navigando, lo sigilla. Anche la Statua della Libertà si concede fiera e vanitosa ai nostri sguardi.
Non manca molto per arrivare a Staten Island. C’è del tempo per parlare di esperienze personali, materiali tecnici, integratori. È un modo per conoscere nuove persone ed ingannare l’emozione. Tra non molto sarò parte del colorato movimento che scandisce l’avvio della manifestazione al quale fino a pochi anni fa non davo alcun significato.
Il villaggio pre-gara accoglie i partecipanti in modo estremamente ordinato. L’ennesimo controllo di sicurezza e poi l’attesa. Bevo un tè caldo, indosso il regalo di uno sponsor preso in uno stand, ossia una cuffia colorata prevista per avvolgere il pensatoio capelluto dalle disattese rigide temperature, approfondisco qualche conoscenza. Comincio a pianificare la gara con un vero atleta, Maurizio De Angelis, che mi propone di correre in coppia. Ma lui merita un capitolo a parte.
C’è gente in ogni dove; un agglomerato di ogni genetica possibile immaginabile e quasi mi stordisce osservare tutta la varietà di persone e comportamenti.
Il tempo scorre e si avvicina il momento fatidico per cui le migliaia di persone presenti si sono preparate da mesi, forse anni. Mentre mi spoglio dall’economica tuta presa per l’occasione dedico un pensiero a chi non ha potuto esserci per svariati e sfortunati motivi. Sono centinaia le persone iscritte che rinunceranno alla maratona ed a loro auguro di far parte ad una delle prossime edizioni.
Il tonfo sordo della prima cannonata oltre a sancire la partenza dei primi atleti preoccupa un po’ tutti gli altri. Gli elicotteri sorvegliano la zona e lo spiegamento di forze di sicurezza è imponente.
Le onde colorate si susseguono velocemente fino al momento in cui è chiamata in causa quella verde di cui faccio parte.
In un attimo mi trovo a correre sul ponte di Verrazzano con una vista su Manhattan che toglie il fiato. Sono attimi che racchiudono un turbinio di emozioni e di energia che nessuno si preoccupa di nascondere. Per la gioia del momento qualcuno ride, qualcun altro urla, c’è chi piange. Poi il silenzio cadenzato dal pulsante suono di migliaia di scarpe ed altrettanti cuori.
Ho studiato abbastanza bene il percorso che sto affrontando per la prima volta e non voglio forzare già alla prima salita. Ho scelto una strategia conservativa.
Nel frattempo il mio cronometro perde il segnale gps e mi riporta valori di passo completamente sballati.
Non è la prima maratona a cui partecipo e vedermi superato dopo poche centinaia di metri da un signore che corre con i mocassini ed un peruviano in costume Inca con tanto di piume in testa non dovrebbe preoccuparmi. Comincio invece a pensare che sto esagerando con il risparmio energetico. Non c’è pubblico fino al terzo chilometro. I lati delle strade di Brooklyn già strabordano spettatori che esibiscono cartelli e tifano come fossero tutti nostri parenti. Grazie alle loro animazioni la lunga e noiosa strada che porta al 13K in prossimità del Brooklyn Academy of Music è scorrevole e divertente. Ci sono gruppi musicali e persone festanti. Scelgo di aumentare un po’ il ritmo ma mi ritrovo nuovamente davanti ad una salita. La strada in questo caso si restringe e la folla è ancora più presente. Cancello dalla mente le strategie distratto dagli incoraggiamenti di centinaia di bambini e dall’onda viola e chiassosa di un magnifico coro gospel organizzato sul marciapiede davanti ad una chiesa. A rendere l’atmosfera silenziosa ci pensa il Quartiere ebraico di Williamsburg dove la partecipazione all’evento è inesistente. Riposo le orecchie. La mezza maratona è fissata nel Queens dove pochi chilometri dopo è presente il famigerato Queensboro Bridge, rinomato per il vento che soffia gelido di traverso sui maratoneti. Una volta attraversato sarò di nuovo a Manhattan. La giornata è talmente bella che veniamo graziati dal meteo così che il ponte non presenta nessun pegno da pagare. Evento unico in 60 anni di Maratona di New York, giurano i partecipanti più esperti. Siamo intorno al 25K e mi rammarica vedere un ragazzo fermarsi per un problema al polpaccio. Non faccio in tempo a pensarci che mi ritrovo a percorrere la curva alla fine del ponte animato da un foltissimo pubblico che festeggia il nostro ingresso a Manhattan come fossimo i primi del gruppo, transitato almeno un’ora prima. La stanchezza e la botta di energia che mi arrivano dritti in faccia quasi mi commuovono.
Gli interminabili sali scendi dell’infinita 1st ave sono la rampa di lancio per cercare di abbassare il mio tempo che è molto al di sopra delle mie possibilità. Sinceramente non sto correndo per fare il mio personal best o per dimostrare niente a nessuno ma voglio dare un senso agli allenamenti svolti durante tutta l’estate. Comincio a sentire bruciore all’interno coscia di entrambe le gambe a causa di un ripetuto sfregamento dei pantaloncini. Per fortuna ai lati delle strade ci sono i volontari che oltre a liquidi ed alimenti distribuiscono anche vaselina spalmata su stecchi simil ghiacciolo. In teoria servirebbero ad evitare l’abrasione ai capezzoli che è una delle cose più dolorose che possono capitare quando corri. Non è facile riuscire a prendere un bastoncino in corsa e cercare di convincerli che sei consapevole di quello che stai facendo. In molti, infatti, scambiano la vaselina per cibo commestibile e se la mangiano. Di conseguenza i ragazzi sono esageratamente premurosi e prevenuti nel concedertene uno. La spalmo e dopo un immediato bruciore mi sento sollevato.
Entro ad Harlem.
Una carica emozionale fortissima mi dà un ulteriore spinta per aumentare il ritmo. Stavolta mi metto a correre seriamente senza dedicare tempo a dare il cinque ai bambini ai bordi delle strade o concentrarmi sulle meraviglie che mi circondano. Mancano circa 10K per entrare a Central Park e mettere fine alla gara più suggestiva che ho corso fino ad ora. È bello accelerare il passo alla fine perché c’è la cosiddetta raccolta dei cadaveri. Quelli che hanno dato tutto nella prima parte di gara e che ora sono in panne. Ne supero davvero tanti ma per recuperare il tempo perso nei primi 30K dovrei viaggiare alla velocità di Kipchoge. Vengo colto dai crampi quasi all’altezza del punto dove l’anno precedente mi ero posizionato per fare foto agli atleti. Impreco, rallento, dialogo con i muscoli, penso alla fortuna che ho questa volta ad essere dalla parte giusta della transenna e mi riprendo in fretta. L’ingresso a Central Park è spettacolare e l’incitamento che non è mai mancato per quasi 35K è commovente. Trovo le ultime motivazioni nella sfida con un altro italiano. Entrambi ne traiamo beneficio tagliando il traguardo con dignità.
C’è qualcosa nell’aria di New York che rende il sonno inutile.
(Simone de Beauvoir)
Un sincero ringraziamento ad Antonio ed Annalisa di Terramia che mi hanno concesso questa fantastica opportunità.